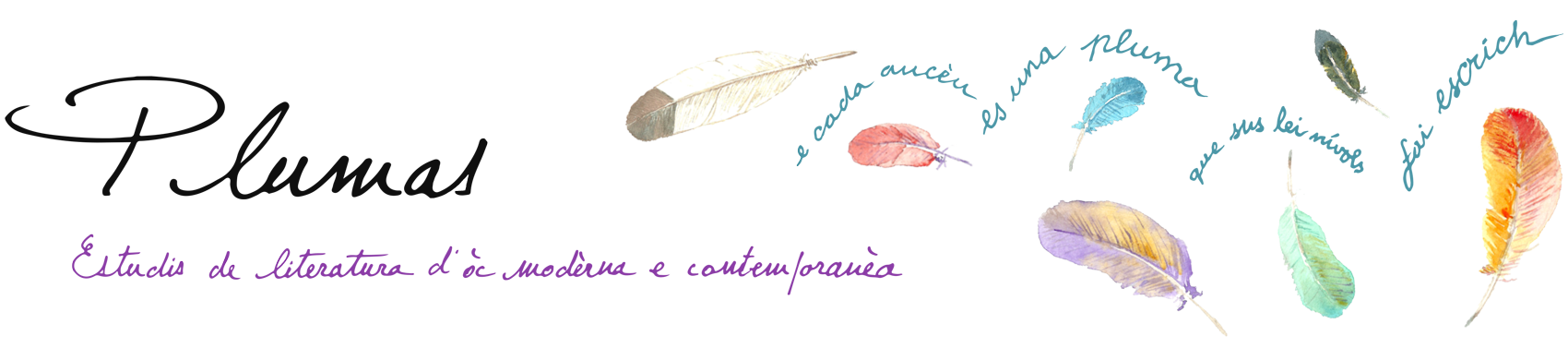« “D’int’ubagu”, dal fondo dell’opaco io scrivo » (Italo Calvino, « Dall’opaco »)
« Tra reirlutz e ubagu »
Lo libre dau reirlutz, del 1979, è la prima raccolta di racconti di Joan Ganhaire1. Il termine reirlutz indica il versante di un monte, o la parete di un muro di una casa, non esposti al sole2. Il primo a spiegarmelo fu Ganhaire. Equivale a ubac (lat. opacus). L’« opaco » e l’« aprico » compaiono tra le varie forme con cui si designa un terreno esposto all’ombra (a tramontana) o a solatìo, dal Piemonte montano sino al ligure di ponente3. E qui s’incontra una testimonianza d’eccezione, quella di Italo Calvino :
Chiamasi « opaco », – nel dialetto : « ubagu », – la località dove il sole non batte, – in buona lingua, secondo una più ricercata locuzione : « a bacìo » ; – mentre è detta « a solatìo », o « aprico », – « abrigu », nel dialetto, – la località soleggiata (Calvino 1994, 98).
Pensando alla sua Sanremo e rispondendo idealmente alla domanda : « che forma ha il mondo » ?, nel racconto « Dall’opaco », del 1971, l’ubagu e l’abrigu segnano per lui una geografia « in pendenza », dove ombra e luce si spartiscono lo spazio tra pendii e anfratti dell’interno, e il mare aperto di fronte (Calvino 1994, 89-101). In questa prospettiva, sembra apparire « l’estrema rarità dell’opaco e la più ampia estensione d’aprico ». Il misterioso confine tra i due è segnato dall’« incupirsi del verde » e dalla « vicinanza del freddo » che denunciano di essere entrati « “int'ubagu”, nell'opaco rovescio del mondo »4.
Ma a seguito di un complesso percorso tra forme dell’altrove, l’ubagu finisce per rappresentare il lato in ombra del paesaggio della sua scrittura :
è inutile che cerchi di ricordare a che punto sono entrato nell’ombra, già c’ero fin dal principio, è inutile che cerchi in fondo all’opaco uno sbocco all’opaco, ora so che il solo mondo che esiste è l’opaco e l’aprico ne è solo il rovescio […] « D’int’ubagu », dal fondo dell’opaco io scrivo (Calvino 1994, 101)5.
Sorprendentemente, Italo Calvino e Joan Ganhaire, usando entrambi la lingua più intima del loro territorio, ricorrono ad analoghe coordinate per descriverci la geografia del proprio immaginario.
È interessante notare un’altra opposizione dialettica e complementare6 esposta negli ultimi scritti di Calvino : la lezione americana sulla « Leggerezza » (Calvino 1995, 631-655). L’autore esprime subito il suo favore (« e sosterrò le ragioni della leggerezza ») verso una qualità che, tracciando un bilancio del suo lavoro quarantennale sulla scrittura, si riconosce in un’operazione costante di « sottrazione di peso ». In proposito ricorda come da giovane scrittore patisse il divario tra il dovere di rappresentare « i fatti della vita che avrebbero dovuto essere la mia materia prima », 632, imperativo dei tempi, e « l’agilità scattante e tagliente che volevo animasse la mia scrittura ». Nell’argomentazione, elencata con la qualità opposta, la pesantezza, compare sovente la parola opaco / opacità :
Forse stavo scoprendo solo allora la pesantezza, l’inerzia, l’opacità del mondo : qualità che s’attaccano subito alla scrittura, se non si trova il modo di sfuggirle. In certi momenti mi sembrava che il mondo stesse diventando tutto di pietra : una lenta pietrificazione più o meno avanzata a seconda delle persone e dei luoghi, ma che non risparmiava nessun aspetto della vita. Era come se nessuno potesse sfuggire allo sguardo inesorabile della Medusa. L’unico eroe capace di tagliare la testa della Medusa è Perseo, che vola coi sandali alati (Calvino 1995, 632).
La sua aspirazione a sfuggire all’opacità del mondo, alla lenta pietrificazione che lo insidiava e rischiava di soffocare la componente volatile della sua scrittura, si esprime attraverso la figura di un Perseo dai sandali alati, sostenuto dal vento e dalle nuvole. Ideale di leggerezza7.
« Entre rire et désespoir »
A proposito di poli dialettici e complementari, di luce e ombra, di leggerezza e pesantezza, Calvino diceva del suo temperamento : « Sono un saturnino che sogna di essere mercuriale, e tutto ciò che scrivo risente di queste due spinte » (Calvino 1995, 674). Adesso Ganhaire visto da Fabienne Garnerin : « Entre rire et désespoir », sono questi i due poli che riscontra presenti nell’intera sua opera. La meditazione sulla morte « qui pèse de tout son poids sur les vivants » e il suo opposto complementare, « le jaillissement d’un rire »8. Passandone in rassegna la ricezione, la studiosa prende ad enucleare dalla critica (Morà, Gardy) i temi che vi privilegia : « la solitude, le désespoir, l’exploration de situations limites et le fantastique » (Garnerin 24). Da medico, d’altronde, le tematiche di Ganhaire non possono che vertere sulla vita, la morte, il dolore e le malattie del corpo e dell’anima. « L’humaine condition », insomma, concernendo esseri vulnerabili e corpi fragili9. Tali temi sono già contenuti in nuce nel Libre dau reirlutz. Eppure, benché anche Ganhaire possa dire « dal fondo dell’opaco io scrivo » e il reirlutz sia la tonalità prevalente nell’opera e nello spirito di questo scrittore, si coglie forte e vivo anche il rovescio dell’ombra, il suo antidoto : le rire10.
C’est que, chez Joan Ganhaire, les contraires ne s’excluent pas l’un l’autre : l’écrivain les pense ensemble, dans une relation dynamique qui invite à questionner la façon dont ils s’unissent. L’oscillation entre rire et désespoir, mais aussi l’alliance inattendue de l’un et de l’autre, éclairent de leurs contradictions la complexité de la condition humaine (Garnerin 17).
Come può l’alipede Mercurio sollevare anche Ganhaire dal suo malinconico Saturno ? Esaminiamo in dettaglio i suoi racconti « dalla parte dell’ombra ».
Accantonando per adesso il primo racconto de Lo libre dau reirlutz, su cui ci soffermeremo in seguito, incontriamo « Raibe negre » (« L’incubo », 15-21). Tra le parole-chiave fantastique, humour noir11, paradoxe qui prende la forma di un vecchissimo mercante di sogni di una fiera ambulante12. Il protagonista è un uomo così sereno da non riuscire che a fare sogni d’oro. Perciò, quando capita che i commensali s’intrattengano a tavola con i loro sogni spaventosi (chauchavielhas), lui rimane senza argomenti salottieri. Decide perciò di procurarsi a tutti i costi un incubo, ottenendone uno micidiale dall’inorridito mercante ; lo chiude in una scatolina che infila nella tasca del soprabito. Ma durante una partita a dama al Caffè della Borsa, viene derubato proprio del soprabito, e il ladro malcapitato morirà di paura al posto suo. Ecco perché, con imperturbabilità e gusto del paradosso, il sopravvissuto celebra ogni volta l’anniversario della sua morte scampata. Non è un esempio di umorismo nero ? Il racconto pare sottilmente burlarsi pure del genere letterario che obliquamente frequenta, ovvero i racconti del terrore, usualmente popolati da incubi che funestano gli uomini, scegliendo come protagonista un signore flemmatico che, per futili motivi, aveva fatto carte false per scatenarne uno.
La medesima impressione di parodia del genere dei racconti del terrore la si ricava da « Lo chasteu » (« Il castello », 23-28), terzo della raccolta, che pare sulle prime disaffiliarsi dal mistero che avvolge i paurosi castelli « a la Edgar Poe » infestati da fantasmi : la stessa noia mortale che vi regna ha provveduto a fugarli. Un devoto domestico ci narra la vita abitudinaria di un Conte, routine che, scandita dall’avvicendarsi delle stagioni, lui ha assecondato per decenni, preparando i panni adeguati alle usuali uscite nel parco del suo signore. Servitore e padrone legano così indissolubilmente le loro vite in un meccanismo ad orologeria che, dopo trent’anni, s’inceppa. È il domestico ad interpretare la noia propria e quella tacita del padrone, mettendovi amorevolmente fine. Prepara perciò per il Conte un completo estivo (fresco di lana e cappello di paglia !) nel bel mezzo di un gelido inverno, completo che, indossato impassibilmente prima della solita passeggiata, ne provoca la morte per assideramento. Una lettera riconoscente del Conte, ritrovata dopo il suo decesso, lo ringrazia preventivamente di averlo liberato da una vita abitudinaria diventata insostenibile. Dunque, dov’è la colpa dal momento che colui che dispensa la morte liberatrice è agli occhi della sua vittima il suo benefattore ? Potremmo incolpare del crimine la stessa noia ‘mortale’ che avviluppa i due, ma la lettera del Conte rivela anche una sorta di maleficio del castello che non lascia via di fuga ai suoi occupanti13. Dunque un castello su cui grava un sortilegio e un aristocratico arrivato alla fine della sua schiatta. Ma non si era detto in esordio che non si trattava di uno dei soliti castelli alla Poe ?
Ne « La chaminéia » (« Il camino », 29-33), troviamo declinata con felpato umorismo (e fantastique) la maledizione atavica del luogo, nella fattispecie una dimora sontuosa, definita non a caso « prèsque un chasteu ». E tale maledizione in questo caso prende la forma più domestica di un malfunzionamento di un camino, quello del gran salone, che sprigiona un fumo subdolo e perfido, nonostante tutte le misure prese dal padrone di casa. In effetti questo fumo indomito sembra quasi emanazione di uno spirito implacato, un genius loci ostile e ribelle a qualsiasi esorcismo tecnologico. Il proprietario, superato il suo scetticismo di uomo di studi, ingaggia perciò un ragazzo, Jan Dau Mas, che in paese ha fama di essere il mago dei camini che non tirano. Il giovane entra in confidenza con il camino e con la padrona di casa che lo assiste nelle sue manovre alquanto stregonesche (carezze, sussurri) che però si rivelano efficaci : il camino riprende a tirare (e la moglie a sorridere) ! Sì, riprende a tirare, ma solo in presenza del suo incantatore, che intensifica sempre più le sue visite sinché non chiede ufficialmente di stabilirsi presso la casa dei signori. Un buon tiraggio e l’appagamento della moglie riportano nella lussuosa dimora l’ordine auspicato dal marito, assorbito nelle sue rigorosissime ricerche d’archivio14…
Come il racconto del Castello stregato, così « Lo bibliotecari » (« Il bibliotecario », 35-39) mette in scena un luogo chiuso e labirintico, una biblioteca, mai visitata da anima viva, ma che pullula dei parassiti del libro, unici a nutrirsi di cultura. L’autore fa un paragone esplicito con un cimitero dove i libri sepolti da polvere e ragnatele sono le spoglie in decomposizione di un sapere inattinto cui pare alludere il nome della biblioteca stessa : la « Font Prigonda », fonte profonda della conoscenza. E morto alla conoscenza è il suo affannato bibliotecario, mero nemico dei vermi del libro, quasi un conservatore di salme da obitorio. La richiesta di prestito che giunge inaspettata di « un omino biondo, viso tondo e ridente » (Ganhaire 38), il quale apre per la prima volta da tanti anni il portone di quell’avello, squarcia l’ombra perpetua in cui da cinquant’anni, sei mesi e diciotto giorni (ha la durata di una severa condanna) il trentasettesimo bibliotecario viveva imprigionato. Situazione kafkiana : troppo tempo il pover’uomo impiega nella ricerca del volume richiesto, troppo tardi risponde all’appello di quella chiamata. Ma una breve esposizione ai raggi del sole del mondo di fuori e la lettura dell’opera faranno comprendere al bibliotecario dove sia la vera vita e dove le tenebre, mentre il suo corpo si avvia a morire, adagiato su quel libro di rivelazione : Il Libro della Notte di Jaufre de Bordelha15.
Anche nel sesto racconto, « Chambra 32 » (« Camera 32 », 41-51), Ganhaire mette in scena un luogo di contenzione, tratteggiando una situazione che risponde ad un tema a lui caro e conosciuto, in quanto formato alla professione di medico : la « riforma morale degli studi medici ». Il fine dell’esperimento di un professore universitario è quello di causare nei futuri dottori una serie di malattie tali da costringerli a patire le sofferenze del malato, provandone compassione. L’« exploration de situations limites » e il meccanismo sadico che escogita, è che un gruppo di studenti in medicina sia reclutato nell’anfiteatro di Psicologia Applicata, sezione Patologia dell’angoscia, dove viene annunciato che sarà loro inoculata una malattia potenzialmente mortale che li ponga davanti al tormento supremo : « Voi siete qui per conoscere la vostra morte, o, almeno, l’eventualità della vostra morte ! Signorine, signori, uno tra voi non uscirà vivo di qui ! Uno di voi morirà di malattia, lentamente ! » (44). Alla fine, restano due amici in agone, ma l’incombere dell’eventualità della morte innescherà i peggiori sentimenti tra i due, gli auspici più spietati : « “Uno di voi. Uno di voi : su, crepa, caro Casteths, svelto, che io esca di qui ! La vita m’aspetta, me, e la clinica di papà […] Su, Casteths, crepa, crepa, svelto, te ne prego !” » (50). Nessuno dei due uscirà vivo dalla Camera 32, prima a morire la loro amicizia…16.
E di un’amicizia, questa volta profonda, di fronte al suicidio tratta il settimo racconto, « A la vita, a la mòrt » (« Per sempre », 53-56). È in forma di monologo di un uomo al capezzale del più caro amico, una morte ostinatamente cercata. È la seconda volta, infatti, che l’Antonin a cui ci si rivolge aveva tentato il suicidio. La prima volta, l’amico lo aveva soccorso in tempo e riportato ad una vita indesiderata. Nel caso della seconda, invece, l’espressione più alta dell’amicizia si traduce nel lasciarlo morire come l’altro ha desiderato17. Tra ricordi di vita condivisa e di complicità, si è indotti a domandarci quale sia il gesto più umano : se salvare a tutti i costi il valore della vita, o rispettare il diritto a morire di un uomo18 « le désespoir, l’exploration de situations limites » qui la fanno da padroni, nella profonda meditazione sulla vita e sulla morte.
« Lo pes daus sovenirs » (« Il peso dei ricordi », 57-73) : ancora il potere malefico delle cose, com’era per l’indemoniato camino della magnifica dimora de « La chaminéia ». A proposito di pesantezza, Ganhaire gioca qui con la doppia valenza del termine « peso » : a pesare terribilmente per le forze di un solo uomo è un pianoforte, ma più ne pesa l’odioso ricordo. « Ti ta ti ta ti ta ta, ta ta ta ti, ta ti ta ta… », qualche nota di Per Elisa, e i ricordi acquattati per anni si sprigionano fatalmente, come per un sortilegio. L’ottavo racconto si apre sul ritorno al paese di quello che è diventato un vagabondo, un uomo che ha rinunciato volontariamente ad una vita agiata, scegliendo la libertà, allo scopo di buttarsi alle spalle i brutti ricordi di un’infanzia di incomprensioni19. Ritrovando un vecchio compagno di scuola che ha fatto fortuna con una ditta di traslochi, vi viene ingaggiato per amicizia e per pietà. Jan, il barbone neo assunto, cadrà dalla finestra nel vano tentativo di traslocare un pianoforte da un piano all’altro di una casa. Prima che le forze lo abbandonino, il ricordo delle frustrazioni di uno studio del pianoforte svogliato e imposto, di uno scarso talento per la musica rinfacciatogli dalla sorella (ah, quel bemolle dimenticato ! « un de quilhs putens de bemòus ! », 65)20 e dall’odiosa maestra di piano21, riaffiorano a debilitarlo. Così Jan, lasciato ancora una volta solo con l’ennesimo peso della vita (« Degun per m’ajudar […] dins quela lucha »), cade sotto il peso dei ricordi e del malefico pianoforte, che sembra aver risvegliato tutta la sua forza maligna di attrazione e distruzione22.
Assolutamente misterioso e dall’atmosfera metafisica è, infine, il nono e ultimo racconto : « La pòrta dau reirlutz » (« La porta dell’ombra », 75-80)23. L’edificio spettrale che svetta dai tetti della città vecchia, e che ha sempre affascinato il protagonista, apre misteriosamente la sua porta. Lui s’insinua in un giardino pieno di rovi e di fiori pallidi, e, passando da dietro (« De queu costat, lo solelh vènia jamai […] Quela pòrta lai era druberta », 77), penetra nei meandri della dimora, che ai rintocchi di un orologio sembra palpitare un’ultima volta per poi richiudersi per sempre. L’uomo vi rimane intrappolato – la Garnerin assimila acutamente la casa a una pianta carnivora – come l’« uccello ipnotizzato dal serpente », impaurito e trepido nella coscienza che quella casa è la sola in cui dimorerà perché lo ha atteso da sempre. Il ricongiungimento ad un labirinto misterioso del tempo dove inabissarsi24. Vi riconosciamo, così, il motivo fantastico della casa / castello stregati, gli ingranaggi senza via di fuga della Biblioteca, con il suo custode kafkiano che vi muore intrappolato, e la morte come porta, accesso a un mistero, il mistero ultimo dell’esistenza25.
« L’ubagu e l’abrigu »
Per riassumere : l’incubo e la paura, i luoghi inesorabili del sortilegio e della reclusione26, la biblioteca borgesiana dai corridoi senza fine, come quello della casa misteriosa dell’ultimo racconto [corridoio senza fine, senza luce, corridoio di lutto] ; i trentasei bibliotecari che hanno preceduto l’ultimo, quali ostie sacrificali della biblioteca, e l’ennesimo eletto che si siede su di una bella poltrona di cuoio (una macchina del tempo del trapasso)27 ne « La porta dell’ombra » ; l’orrore della malattia e della morte, « l’insostenibile peso del vivere » (Calvino 1995, 651 cita Leopardi), il peso dei ricordi (la pesantezza !), il mistero oltre la vita. Esistenze umbratili lentamente erose da meccanismi più grandi di loro, che le fagocitano (gli abitanti annoiati del castello, la genealogia polverosa dei bibliotecari, l’aspirante suicida in ascolto di un altro mondo, l’uomo attonito che varca la soglia dell’algida, ultima casa). Joan Ganhaire s’interroga (ci interroga) sul senso della vita e della morte. Ma, come si è visto per Calvino, anche in Ganhaire urge una provvidenziale aspirazione alla leggerezza che stempera il suo lato oscuro alla luce del suo inguaribile sorriso (« le jaillissement d’un rire ») : l’opaco e l’aprico, l’ombra e il raggio di sole, il male e il suo contravveleno. L’aprico è la scintilla dell’umorismo (lo si riconosce anche in Kafka), il distacco ironico, l’indulgenza umana che mitiga e allevia la sua indignazione e talvolta perdona e assolve. E il gusto del paradosso che dà un senso alle apparenti contraddizioni della vita. Insomma, è davvero colpevole il servitore devoto che pianifica la vita, come pianifica la morte per assideramento del suo amato Conte, ne « Il Castello » ? E quanto sono ridicoli i rituali meticolosi con cui il cerimonioso domestico prepara i vestiti per il suo manichino ! E l’angelo della luce che apre la porta della biblioteca, squarciando le tenebre in cui vive il bibliotecario, non chiede un Libro della notte, dove si parla solo di « luce, di vita, di sole che non brucia gli occhi » ? La stessa lotta tra sole / vita e ombra / morte de « La porta dell’ombra »28. E nel secondo racconto, l’incubo stregonescamente scatenato non ti va ad uccidere un ladro malcapitato, beffa del destino, e non chi lo aveva procurato, che, imperturbabile, celebra ogni anniversario, sulla tomba dell’altro, la sua morte mancata ? Così, anche gli oggetti si animano di vita propria e, con una forza nefasta, eseguono la loro lenta vendetta ( « Il peso dei ricordi ») o insidiano subdolamente i padroni di casa, come il fumo ne « Il camino ». Una tregua dall’opaco più profondo, ironica e spassosa, sembra proprio « La chaminéia » : perché il camino di due agiati signori sprigiona fumo, in un ménage che pare perfetto, almeno al distratto padrone di casa ? E quanto è arguta e maliziosa l’« estranja conclusion » dello spazzacamino : « vòstra chaminéia es amorosa de ió » (il genere femminile rende perfetto lo scambio con il soggetto reale). Ed il rimedio (il portentoso stura-camini) è peggiore del male, o è, paradossalmente, il prezzo accettabile per il quieto vivere ? 29. Insomma, anche nel primo libro di Ganhaire, Lo libre dau reirlutz, si nota quella miscela di disperazione e di riso indulgente che coglieva con acume Fabienne Garnerin nel suo Entre rire et désespoir.
« Tra civette sole»
Sicuramente, anche da quanto risulta da questi semplici riassunti del Libre dau reirlutz, la sua propensione al fantastico orienta verso autori che Ganhaire stesso riconosce tra le sue influenze letterarie prevalenti30. Se abbiamo isolato il primo racconto, « Soletat » (« Solitudine », 9-13), è perché intanto vi scorgiamo una variazione su un tema, quello della comunicazione tra uomo e animale, che avrà molto risalto in larga parte dell’opera di Ganhaire, specie quella a carattere comico e d’ambientazione rurale. E poi perché ci sembra che apra un piccolo spiraglio verso l’immaginario di Calvino. L’ombra che ammanta o lambisce i personaggi della raccolta dau reirlutz, nel primo racconto concerne proprio lo stato di disadattamento del protagonista rispetto al consorzio umano, che si riflette nella sua incapacità di comunicare con gli individui della sua specie. Da ciò il suo stato di sofferta solitudine (Garnerin 65). Ma l’uomo è un animale sociale, e difficile è resistere dal cercare qualche forma di amicizia 31… anche se alquanto inusuale. Ascoltando una sera la voce di tre civette che gli sembrano rispondersi :
ci unii la mia, che feci più stridula possibile. Con mia grande vergogna, calò un silenzio di biasimo. A rischio di scoraggiare gli uccelli, ricominciai, una volta, due, sempre più convinto. La voce del nord fu la prima a rispondere, seguita da quella da levante, poi da quella da ponente. Quando venne il mio turno, feci la mia parte da civetta (Ganhaire 10).
Tale e tanta la solitudine, tale l’urgenza di parlare con qualcuno, di comunione, di appartenenza, da invogliare il solitario del racconto a tentare un salto di specie per cercare un’intesa con tre civette. Ne studia il canto distinto (una voce un po’ rauca, un’altra un po’ tremula), abbandonandosi all’immaginazione di una vecchia civetta dal manto arruffato e dagli occhi d’oro. Presto le tre voci diventano, per il solitario, « mas tres amijas » :
Mie tre amiche, mie tre voci della notte, continuate a parlarmi, gonfiate ancora una volta le vostre gole ! Ancora una volta lasciatemi rispondervi, io che non ho nessuno con cui parlare ! Se voi sapeste la gioia profonda che provo, non tacereste mai, voi che mi avete quasi fatto tornare il gusto di vivere, a me per cui i giorni non sono altro che l’attesa della notte piena della nostra conversazione ! (Ganhaire 11).
Accade un giorno che il solitario abbia necessità di scendere in paese per alcune commissioni, qualche spesa e al Caffè della Posta per concedersi una buona birra. Là, casualmente, fa una scoperta sconvolgente :
Tutto d’un tratto, una voce familiare mi fece voltare : era lo stridio rauco di Giraudon. Prima che avessi avuto il tempo di domandarmi che ci faceva lì la mia amica, la vidi, la mia civetta dagli occhi d’oro pieni di cose di un tempo che fu : era un ragazzone fulvo, ubriaco fradicio, che i suoi compari, con stupidi sghignazzi, incoraggiavano a voce : « Su, Marceu, facci ancora la civetta ! Su, ancora ! » E il ragazzo cacciò il suo grido dolente tre, quattro, cinque volte, prima di addormentarsi, singhiozzando, in una pozza di vino bianco. (Ganhaire 11-12).
« E lo goiat uchet son crit dolent » : non è un caso che i disadattati «dei quattro venti»32 si identifichino con animali schivi e notturni, e il cui verso è associato ad una fama infausta, un lugubre planh33. Davanti all’atroce dubbio che anche le restanti due « civette » non fossero che degli idioti, dei poveri illusi che « se crèsian boirar aus auseus », lui, la « choita de Puei Jobert », si apposta e li sorprende, uno dopo l’altro, a imitare le civette in quel solito, assurdo « rituau ». La delusione e l’indignazione inducono sulle prime nell’uomo lo sfogo di un’invettiva :
Gli volevo dire che noi quattro eravamo dei poveracci, che non avevamo un posto né tra gli uomini, né tra gli uccelli, anche i più tristi, i più maledetti (Ganhaire 13).
Ma all’indignazione subentra la pietà per la condizione umana dei tre, e per la propria, che lo riduce all’indulgenza, prolungando questa illusione corale34 :
Ma prima di far tacere per sempre quelle tre strida da operetta, tesi l’orecchio un’ultima volta : nord, levante, ponente… Giraudon, Puei Negre, Mironcelas… Allora, intesi ; intesi che il ragazzone fulvo aspettava un pochino prima di lanciare di nuovo il suo grido, più dolente ancora che dal più profondo della sua ubriachezza : era me che aspettava, ero io che mancavo.
Allora, invece della mia maledizione, invece del mio odio, tirai fuori nella notte il più bel grido di civetta che si sia mai levato dalla gola di un uomo. (Ganhaire 13).
Uomo o civetta, era lui che gli altri attendevano per colmare le loro solitudini35. Il protagonista di « Soletat » è dunque un uomo in balia del suo bisogno comunicativo, che s’illude di soddisfare entrando in dialogo con l’alata famiglia. Illusione e disinganno. Il primo inganno è proprio quando il solitario crede di insinuarsi in un altro dominio linguistico, scimmiottando il verso delle civette (« me damandí […] si ávian pas conegut l’òme dernier la votz », 10), verso già contraffatto in partenza perché emulato (lo si saprà in seguito) da esseri umani altrettanto soli. Quindi, la più ovvia confluenza (e scambio) di campi lessicali è quella tra voce umana e verso animale, posto che, tragicamente, si riveleranno tutti emessi dai medesimi locutori. Il racconto di Ganhaire, dunque, è sapientemente costruito sull’ambiguità e l’intersezione tra il campo umano e l’ornitologico, a partire da intrecci lessicali che ne esprimono la fusione e la confusione. Per esempio, le risorse linguistiche di Ganhaire gli consentono di costruire una costellazione semantica omogenea a partire da choita, la civetta. Infatti, a questa voce limosina si collegano i vari derivati choitonar, choitonanta, choitonada, choitonament che designano il suo verso in senso specifico36, alternato al termine votz, comune anche agli umani37. Questo non è concesso alla lingua italiana38. E la percezione falsata (auspicata) del protagonista giunge a scambiare l’intreccio degli choitonaments per una vera conversazione e un dialogo umani (nòstre parladís, (10) ; contunhatz de me parlar, nòstra conversacion, 11), sinché non scopre che quei conversari sono dei volgari « choitonaments d’opereta » (13). Altre sono le infiltrazioni lessicali di questa ridicola / patetica contaminazione dei due domini. Per esempio, non può essere un caso che il protagonista, sceso in paese per sbrigare qualche faccenda, designi il suo rifugio posto « a la cima d’un terme », in vetta a un poggio (Puei Jobert), con il termine familiare di quincaròla, (11), ovvero cima, sommità di un albero (Lavalade 471). Il traduttore francese, in questo caso, usa perchoir, trespolo, posatoio. Nella medesima direzione va enjucat (12), riferito ad una delle quattro false civette che il protagonista spia appollaiata su di un ramo di quercia, lato a vista della sua immedesimazione con il pennuto. Questa « civetta rampante » mi ha fatto volare il pensiero verso Calvino.
Il solitario che cerca di instaurare un dialogo con degli animali non è un unicum nell’universo letterario di Ganhaire. La catena tra uomo e animale, infatti, non vi conosce interruzioni, dal vero e proprio ibrido (infausto) nel leberon, l’uomo-lupo de Lo darrier daus Lobaterras, all’empatica intimità che s’instaura nel mondo rurale tra contadini e animali domestici, fra cui si cementa un sistema condiviso di segni e un dialogo privilegiato. Oppure, l’intesa complice tra l’« adulte solitaire » e la lepre novellatrice in Çò-ditz la Pès-Nuts. Tale tema attraversa, in particolare, il mondo contadino riflesso in chiave comica in opere quali Cronicas de Vent-l’i-Bufa (storia collettiva e quotidiana degli abitanti del villaggio immaginario di Chantagreu sus Claraiga, Ganhaire 2016), o Los braves jorns de Perdilhòta (Ganhaire 2013). Anzi, è un mondo dove tutti gli elementi comunicano con gli uomini, persino il suono delle campane (« lo lengatge de las clòchas ») portato dai venti (così presenti anche nella geografia di « Soletat »)39 per poggi e valli, e che il contadino commuta in moniti verbali per regolare il ritmo giornaliero del lavoro nei campi (Ganhaire 2013, 18). Fabienne Garnerin coglie benissimo questo concento di segni, la comunione emotiva e questa relazione tra uomo e animali (il velo nero per il lutto, per esempio) :
Omniprésents dans le monde rural, les animaux domestiques font partie de la famille. Ils en partagent les joies et les peines, auxquelles ils sont officiellement associés par des pratiques traditionnelles. À la mort du père, la grand-mère, l’héroïne de la nouvelle « La mamet dispareguda » [La grand-mère disparue] « deguet ’nar parlar aus bestiaus e botar un pelhon negre aus bornats » [dut aller parler aux bêtes et mettre un chiffon noir sur les ruches]. Bêtes et abeilles comprendront les signes rituels… (Garnerin 53).
Ed è significativo che questa inclinazione verso gli animali da compagnia concerna in particolare uomini soli, prosegue Garnerin :
Les animaux familiers sont dignes d’affection, autant que les hommes et parfois plus. Les célibataires ou veufs qui n’ont personne à qui parler ont de longues conversations avec leur chien ou leur animal de trait. Dans la nouvelle « Un meschent bestiau », Tranuja, vieux célibataire40, a pour toute compagnie son ânesse Friquette41.
E dunque perché l’intesa uomo-civetta si rivela così infelice in « Soletat » ? Ma perché, oltre che un ibrido irrisolto, siamo in presenza di una penosa finzione umana. Anzi, una suggestione divertente potrebbe reclutare persino l’antica modalità venatoria di cacciare con la civetta, usata come richiamo (in it. civettare), dov’è l’idea di inganno, tranello, camuffamento. Esca in cui sarebbe caduto incidentalmente il solitario di « Soletat ». Come che sia, la natura fittizia e ambivalente di questo gioco di ruolo mantiene per tutto il racconto la sensazione che permanga lo spunto comico di uno scherzo ai danni di un uomo ingenuo e vulnerabile. Insomma, qualcosa che somiglia all’inizio a una burla paesana42 (ricorda un po’ l’atmosfera delle nhòrlas tanto amate da Ganhaire)43, la cui carica umoristica non soccombe del tutto, a mio parere, neppure via via che nel corso del racconto il ridicolo cede al suo risvolto più patetico e drammatico, quello della pietà per la condizione umana. Sino all’acuto del finale. Insomma, anche qui convivono le rire e le désespoir.
« Il barone rampante e i merli di Palomar »
Finito il suo lungo viaggio tra le Fiabe italiane (Calvino 1993), Calvino si domandava : « riuscirò a rimettere i piedi sulla terra ? ». La domanda che lo scrittore si poneva non può che traghettarci verso Il barone rampante ( Calvino 1991, 547-777), del 1957, partorito da una gestazione comune con le Fiabe italiane. A non rimettere più letteralmente i piedi sulla terra sarà Cosimo, il protagonista. Com’è noto, il piccolo Cosimo Piovasco di Rondò, il 15 giugno 1767, si ribella alla disciplina familiare (e a un piatto di lumache), andando a vivere sugli alberi della villa, la villa d’Ombrosa. E lì vivrà sino alla vecchiaia, separato sì dagli altri, ma completamente partecipe della filosofia e della storia del suo tempo. La vita culturale parigina lo celebra come « L’homme sauvage d’Ombreuse » (697) e Voltaire lo rammenta come « ce fameux philosophe qui vit sur les arbres comme un singe » (698). Cosimo, « sur les arbres », cerca di attirare l’attenzione dell’amata Viola con richiami di uccelli (il verso della beccaccia, il fischio della pernice grigia, il triste verso del piviere, il tubare dell’upupa, il trillo della pispola, 707-708). Vestito di penne, si fa paladino dei pennuti, e scrive addirittura dei trattati, quali, non a caso, Il verso del Merlo e I Dialoghi dei Gufi (736). Le civette compaiono, insieme ad altre diavolerie e teschi di animali, nei rituali della « Massoneria all’aperto » (746). Come tutta l’opera di Calvino, anche questa è pervasa da uno spirito comico-fantastico44, vena che di sicuro costituisce un ponte con Ganhaire. Cosimo, campione di leggerezza (in procinto di morire, volerà via aggrappandosi ad una mongolfiera) è un uomo « perché », come la civetta più mimetica di « Soletat », inselvatichito, ma mai alienato, né tantomeno disperato, come i solitari del racconto di Ganhaire. Questo libro di Calvino è anche l’unico punto di contatto esplicito con Ganhaire : « D’Italo Calvino, je n'ai lu que “Le baron perché”. Il ya très longtemps et je ne m'en souvient que très peu. Je vais le relire », mi dichiara in una mail a proposito del « romanzo arboreo » di Calvino. « ça n'a sûrement eu aucune influence sur mes écrits » : sono infatti semplici punti di convergenza che, se non bastano a fondare una parentela letteraria e non si configurano quindi come una vera influenza, tuttavia tracciano, come nel caso di reirlutz-ubagu, affinità immaginative su cui, a mio avviso, non è inutile riflettere.
E siamo così arrivati al tema che riguarda il linguaggio umano e quello animale, con i loro eventuali scambi comunicativi45, e che presenta analogie interessanti tra Ganhaire e Calvino. C’è un libro famoso di Italo Calvino, Palomar, dove mette il taciturno, solitario e meditabondo protagonista alle prese con la complessità dell’universo che lo circonda (Calvino 1992, 871-979). Il mondo animale vi è molto presente46, oggetto di osservazioni minuziose (porta il nome del noto osservatorio astronomico, che a sua volta rimanda a una piccionaia / colombaia : palomar) e di riflessioni antropologico-culturali sul loro comportamento e il loro linguaggio. Ne « Il fischio del merlo », in particolare, Palomar, oltre a cimentarsi in una classificazione « in categorie di complessità crescente » dei versi degli uccelli (cinguettii, trilli, zirli, chioccolii, gorgheggi), s’interroga sul senso del canto di una coppia di merli, avanzando analogie e interferenze con il modo della comunicazione umana. Analogie che finiscono per coinvolgere la coppia Palomar e signora, paragonata a « i merli marito e moglie », e le rispettive conversazioni (Calvino 1992, 891-896 )47 :
Il fischio dei merli ha questo di speciale : è identico a un fischio umano, di qualcuno che non sia particolarmente abile a fischiare […]. Dopo un po’ il fischio è ripetuto — dallo stesso merlo o dal suo coniuge— […] se è un dialogo, ogni battuta arriva dopo una lunga riflessione. Ma è un dialogo, oppure ogni merlo fischia per sé e non per l’altro ? […] Oppure tutto il dialogo consiste nel dire all’altro : « io sto qui », e la lunghezza delle pause aggiunge alla frase il significato di un « ancora », come a dire : « io sto ancora qui, sono sempre io ». E se fosse nella pausa e non nel fischio il significato del messaggio ? Se fosse nel silenzio che i merli si parlano ? […] Oppure nessuno può capire nessuno : ogni merlo crede d’aver messo nel fischio un significato fondamentale per lui, ma che solo lui intende ; l’altro gli ribatte qualcosa che non ha nessuna relazione con quello che lui ha detto ; è un dialogo tra sordi, una conversazione senza capo né coda. Ma i dialoghi umani sono forse qualcosa di diverso ? ( Calvino 1992, 892-893).
Salvando la complessità della « dubitosa sapienza » di un Calvino che veste i panni del signor Palomar, le osservazioni sul senso del fischio del merlo presentano similarità con quelle sul verso della civetta del solitario di Ganhaire, compreso il tentativo di dialogo che Palomar intraprende con i merli (Calvino 1992, 895-896 ) :
Dopo aver ascoltato attentamente il fischio del merlo, egli prova a ripeterlo, più fedelmente che può. Segue un silenzio perplesso, come se il suo messaggio richiedesse un attento esame ; poi echeggia un fischio uguale, che il signor Palomar non sa se sia una risposta a lui, o la prova che il suo fischio è talmente diverso che i merli non ne sono affatto turbati e riprendono il dialogo tra loro come nulla fosse.
Continuano a fischiare e a interrogarsi perplessi, lui e i merli.
Ne differisce, va da sé, come nel caso di « Dall’opaco », una prosa che in Calvino si organizza secondo un pensiero problematico e sistematico complesso, mentre il focus della penna di Ganhaire resta concentrato sui risvolti umani delle vicende, e la sua vena si conferma squisitamente narrativa.
« quella unità e parentela di tutto ciò che esiste al mondo, cose ed esseri viventi »
Fauna, flora, regno minerale, firmamento inglobano nella loro comune sostanza ciò che usiamo considerare umano come insieme di qualità corporee e psicologiche e morali (905)
corrisponde alla sola, certa filosofia delle Metamorfosi : « quella unità e parentela di tutto ciò che esiste al mondo, cose ed esseri viventi (914).
Così commenta Calvino a proposito della contiguità dèi-uomo-natura, in un suo saggio molto bello sulle Metamorfosi di Ovidio, un maestro che lo accompagnerà sino alla lezione americana sulla « Leggerezza »48. Villa Meridiana, a Sanremo, parco di acclimatazione di piante tropicali, costituì un piccolo Eden per Italo, insieme a Villa Terralba del nonno Calvino, orizzonte dell’immaginario dei suoi Antenati. Trilogia degli antenati che Calvino stesso definì attraverso l’immagine emblematica di un albero genealogico dell’uomo contemporaneo. Era la San Remo (così scriveva lui) della sua infanzia, stazione climatica dove mare, campagna e spazi urbani si conciliavano, la sua città poi perduta per una forsennata speculazione edilizia. Quanto alla cultura familiare, è noto che il padre di Calvino fosse agronomo e la madre botanica e impegnata nella protezione degli uccelli. Anche se Calvino ricercherà nella letteratura, oltre al retaggio scientifico familiare, una sua chiave di accesso alla natura, permane in lui la ricerca di un ideale dove il mondo modellato dall’uomo dovrebbe vivere in armonia e comunione con l’ambiente naturale49. Questo aspetto è già molto noto e studiato perché qui ci si debba dilungare. In particolare, Gli animali di Calvino, titolo di un noto saggio critico, esamina recentemente la precoce e pervasiva attenzione di Calvino verso l’altro non-umano ( si parla di « umanesimo non-antropocentrico »), alla luce di una visione complessiva che accomuna l’uomo e l’ambiente in un unico destino sulla terra50 :
Vi siete mai chiesti che cos’avranno pensato le capre, a Bikini ? e i gatti nelle case bombardate ? e i cani in zona di guerra ? e i pesci allo scoppio dei siluri ? Come avranno giudicato noi uomini in quei momenti, nella loro logica che pure esiste, tanto più elementare, tanto più ̶ stavo per dire ̶ umana ? […] Sì, noi dobbiamo una spiegazione agli animali, dobbiamo chieder loro scusa se ogni tanto mettiamo a soqquadro questo mondo che è anche il loro51.
L’eco-critica di oggi si gioverebbe moltissimo, a nostro avviso, della conoscenza, ancora poco diffusa, di gran parte della letteratura occitanica moderna e contemporanea, per fare solo un nome che ha avuto consonanze con Ganhaire : Marcela Delpastre52.
Quanto a Ganhaire, il suo amore per la natura, gli alberi, le piante, le fonti, i corsi d’acqua della sua terra è pervasivo, come dimostra Fabienne Garnerin in una parte del suo studio su « l’Univers littéraire » di Ganhaire intitolato « Une Aquitaine recomposée », Garnerin 27-38. Si è parlato di animismo esteso al mondo vegetale e alle cose stesse che talvolta prendono vita in forma ostile (nel Libre dau reirlutz, il pianoforte, il camino, la « petite boîte » che contiene l’incubo) o ludica (il berretto simbiotico di Massime)53, animismo della vecchia cultura contadina, che arriva a fondere in un’unica catena i sistemi di segni dei diversi regni :
L’animisme de Maxime mêle humains, animaux et objets dans un collectif unique qu’on pourrait qualifier de familial, où se retrouvent la Zélia, Yvette et son mari, la mule Friquette, le chien Ranfort ainsi que les bêtes présentes dans la ferme, son béret bien aimé, l’autre béret qu’il déteste et lui-même. Sa mule Friquette et son chien Ranfort sont ses deux confidents. Ranfort fait le lien entre les éléments non-humains extérieurs à la maison et les humains qui y habitent […] Ranfort sait participer au langage du vent, des tilleuls et de la pluie ; mais il sait aussi communiquer avec les hommes (Garnerin 216-217).
Anche questo aspetto, già censito e analizzato con la solita perspicacia, si trova, una volta per tutte, nell’opera critica della Garnerin.
In forme talvolta affini, talaltra diverse, ma non inconciliabili, i due scrittori ci parlano di natura, di alberi e di animali. Alla fine del Barone rampante, Calvino, constatando malinconicamente « Ombrosa non c’è più », parla del filo d’inchiostro che si ramifica, si biforca, si attorciglia, « si sdipana e avvolge un ultimo grappolo insensato di parole idee sogni ed è finito » 54. Insomma, la scrittura stessa che si fa acini, semi, foglie, nuvole e rigenera le piante antiche del ricordo, andate perdute per « la furia della scure ». Per Ganhaire, la foresta di Feytaud disboscata per gli interessi degli uomini in Lo darrier daus Lobaterras. In un modo suo di sensibilità “ecologica” della letteratura, Ganhaire, con il suo filo d’inchiostro, ha rinfoltito il patrimonio culturale della sua terra, il suo paesaggio letterario, irrorandoli con la linfa della sua immaginazione (« totjorn a un piau dau fantastique… »)55. Per Ganhaire, inoltre, consacrare tutto il suo impegno letterario alla lingua limosina ha significato fecondarne le potenzialità espressive e rafforzarla contro il dilavamento a cui secoli di egemonia della lingua francese l’hanno condannata. Atto di lealtà verso la sua identità occitana riscoperta, e di riparazione verso le ferite della storia di una cultura minorizzata. Atto fiero e amorevole, proprio del medico che cura i suoi malati con le parole a loro familiari e rinsalda, con la sua scrittura talentuosa, le radici della lingua della sua cultura.